Lodovico Vittorio Savioli
Poeta, Storico, Collezionista e Connaiseur

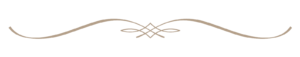
Lodovico Vittorio Savioli
Poeta, Storico, Collezionista e Connaiseur

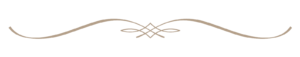
Negli anni in cui veniva ampliato e decorato palazzo Savioli come lo vediamo ora, era certamente figura di grande rilievo in una famiglia di autorevoli relazioni internazionali e di non trascurabili interessi culturali il conte Ludovico Vittorio Savioli (1729-1804). Senatore e accademico bolognese, negli anni giovanili poeta di larga fama per la raccolta di anacreontiche gli Amori, poi storico della sua città con gli Annali bolognesi e sempre, nel corso della sua vita, connaisseur e collezionista, il Savioli nel 1772, per celebrare il proprio accesso al gonfalonierato, massima magistratura bolognese, ordinò il rifacimento del palazzo, già dei Fontana Barbieri, e ne progettò la decorazione. Nelle sue scelte si riflette quindi, oltre al prestigio della casata che voleva affermare, lo stile e la cultura sua personale.
I conti Savioli, dapprima cittadini della Repubblica di Venezia, legati per tradizione familiare e per importanti ruoli civili e militari all’Impero (Alessandro senior, il nonno di Ludovico Vittorio, era stato Amministratore generale delle Poste austriache a Venezia al servizio di ben tre imperatori, e forse non estraneo a operazioni di intelligence), poi cittadini bolognesi dal 1712, si erano definitivamente trasferiti dal 1728 a Bologna, divenendo sudditi del Papa, a seguito di importanti matrimoni con nobili bolognesi. Nel 1772, Ludovico Vittorio Savioli, che come primogenito assommava in sé il maggior censo e un ruolo importante nell’amministrazione pubblica di Bologna, con l’accesso al gonfalonierato coronava l’ascesa sociale iniziata da Alessandro senior e rappresentava bene l’eccellenza politica, culturale, di relazioni autorevoli anche internazionali, di costumi e di eleganza della famiglia.
 Il ritratto giovanile ne mette in luce, con la ricchezza e il prestigio, la cultura letteraria e scientifica e l’attività poetica, all’epoca rappresentata da Il monte Liceo. Il 12 maggio 1769 il Savioli scriveva all’abate Lodovico Preti, Minutante di segreteria di Stato in Roma, chiedendo il rinnovo triennale della licenza dei libri proibiti e, insieme, la facoltà di acquisto e lettura di tre testi che gli stavano particolarmente a cuore, due dei quali abitualmente esclusi dalla licenza: un testo di Machiavelli, uno di Lucrezio e il Dictionnaire di Bayle3. Nella lettera il Savioli minimizza, per evitare dinieghi, la portata delle sue richieste, dissimulando dietro la passione estetizzante del collezionista i suoi non convenzionali interessi culturali: «La raccolta di libri, che ho cominciata, e che però non ardisco ancor di chiamar libreria, fà ch’io desideri facilità maggiore».
Il ritratto giovanile ne mette in luce, con la ricchezza e il prestigio, la cultura letteraria e scientifica e l’attività poetica, all’epoca rappresentata da Il monte Liceo. Il 12 maggio 1769 il Savioli scriveva all’abate Lodovico Preti, Minutante di segreteria di Stato in Roma, chiedendo il rinnovo triennale della licenza dei libri proibiti e, insieme, la facoltà di acquisto e lettura di tre testi che gli stavano particolarmente a cuore, due dei quali abitualmente esclusi dalla licenza: un testo di Machiavelli, uno di Lucrezio e il Dictionnaire di Bayle3. Nella lettera il Savioli minimizza, per evitare dinieghi, la portata delle sue richieste, dissimulando dietro la passione estetizzante del collezionista i suoi non convenzionali interessi culturali: «La raccolta di libri, che ho cominciata, e che però non ardisco ancor di chiamar libreria, fà ch’io desideri facilità maggiore».
Aggiunge che non è disposto a privarsi di due edizioni delle opere del Machiavelli e del Marchetti «che sono libri di costo, e d’ornamento grande a una libreria». Espressione, questa, buttata lì quasi per caso ma che di nuovo pone in evidenza il valore del libro come oggetto d’arte, sospingendone in ombra la portata ideologica. Quanto al Dictionnaire di Bayle, non vorrebbe che gli venisse vietato, tanto più che lo ha già ordinato. Da tempo il Savioli, secondo una pratica assai diffusa, era solito far venire libri dall’estero attraverso corrispondenti o amici. Nel 1765 il suo corrispondente da Londra era Giuseppe Baretti. Un abito di disinvolta convivenza con la censura sembra ormai acquisito anche a Bologna e si stentava a pensare che l’intellettuale di provata ortodossia non fosse norma a se stesso.
Come già nel 1754 sembrava suggerire l’aforisma estratto dalle Lettres persanes di Montesquieu e premesso da Francesco Maria Zanotti, en exergue, come programma e monito, alla sua Filosofia morale: «Les moeurs font toujours des meilleurs citoyens que les lois». Questa intima consapevolezza è quella che fa dichiarare al Savioli, sempre nella lettera a Preti, l’ultima richiesta, di gran lunga la più importante, che è di avere la licenza dei libri proibiti perpetua, vale a dire una volta per tutte. E qui il tono del Savioli si vena di amarezza: «Ella sa ch’io mi accosto ai quaranta, ch’io fò professione di non vivere in ozio e sono Academico dell’Istituto».
In effetti i volumi di cui il Savioli intendeva provvedersi erano tutti opere di successo in edizioni di pregio. Il «Macchiavello bellissimo di stampa di Londra» può essere l’edizione di tutte le opere in italiano in due volumi, in -4°, del 1747 ma anche le Opere inedite, Londra, 1760, in -4°. Mentre il Dictionnaire di Bayle è, con tutta probabilità, l’edizione di Parigi del 1760, la migliore e la più ricercata dopo quella assai rara del 1720, che contiene la duplice stesura dell’articolo David. Quanto alla «edizione ultima del Marchetti», essa è certamente la traduzione del De rerum natura lucreziano uscita a Venezia nel 1768. Erano opere condannate senza remissione dalla Congregazione dell’Indice né più riabilitate.
Nel 1769 il Savioli era dunque impegnato a costituire una biblioteca di pregio per scelta dei testi e rarità delle edizioni mentre mimetizzava dietro la passione del connaisseur interessi a correnti speculative tra loro comunicanti e tutte più o meno situate di qua dalle dottrine e dai metodi peripatetici. Da Bayle, il sostenitore della tolleranza, che aveva applicato il libero esame ai testi sacri, riferendoli continuamente alla morale naturale, alla illustre tradizione risalente a Machiavelli, tutta dedita agli studi storici ed eruditi sull’antichità e ancora ben viva in Francia. Infine, con la traduzione del Marchetti, alle concezioni filosofico-scientifiche non lontane da quelle atomistiche.
Erano testi ritenuti dalla censura ecclesiastica fra i più pericolosi e nocivi. Se questi testi vietati costituivano, se così si può dire, la punta di un iceberg e delineavano il limite di massima espansione di rischio degli interessi del Savioli, molte altre e variate erano le sue letture, come attesta l’indice della sua biblioteca, compilato nel maggio 1804, pochi giorni dopo la sua morte. La raccolta comprendeva una ricca collezione di testi francesi, inglesi e tedeschi, oltre che italiani e latini, e vi figuravano prevalenti, a fianco dei volumi di letteratura e di poesia, testi di storia delle nazioni europee e della Chiesa, come pure di dottrina politica e legislativa, né mancavano le edizioni complete delle opere di Montesquieu, di Voltaire, di Mably, di Rousseau.
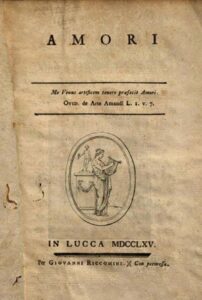 Tutte letture che delineano un preciso interesse del Savioli per la storia politica, giuridica e amministrativa europea nella direzione di una interpretazione dei testi antichi di indirizzo illuministico. Fino ad allora il conte Savioli era conosciuto e apprezzato soprattutto come poeta, autore di quella straordinaria opera letteraria, cosiddetta minore e prodotto di consumo, che sono gli Amori. Un’opera alla quale arrise subito e per tutto il Settecento un rilevante successo di critica e di pubblico. Ne fanno fede le decine di edizioni, ben presto esaurite, che si susseguirono dopo la prima, incompleta, del 1758, e la seconda, che riuniva ventiquattro canzonette, uscita a Lucca nel 1765 per i tipi dell’editore Riccomini, fino alle bellissime bodoniane e a quella parigina del 1785.
Tutte letture che delineano un preciso interesse del Savioli per la storia politica, giuridica e amministrativa europea nella direzione di una interpretazione dei testi antichi di indirizzo illuministico. Fino ad allora il conte Savioli era conosciuto e apprezzato soprattutto come poeta, autore di quella straordinaria opera letteraria, cosiddetta minore e prodotto di consumo, che sono gli Amori. Un’opera alla quale arrise subito e per tutto il Settecento un rilevante successo di critica e di pubblico. Ne fanno fede le decine di edizioni, ben presto esaurite, che si susseguirono dopo la prima, incompleta, del 1758, e la seconda, che riuniva ventiquattro canzonette, uscita a Lucca nel 1765 per i tipi dell’editore Riccomini, fino alle bellissime bodoniane e a quella parigina del 1785.
Il nucleo germinativo delle canzonette, immerse in un clima di divagazione fantastica tra modernità e mito, di argomento erotico ma non licenzioso, si colloca nel sodalizio letterario che il Savioli, giovanissimo, aveva avuto con il medico e poeta An- gelo Michele Rota, suo precettore, allora giovane ma già esperto maestro. Sodalizio incentrato sulla riscoperta dei poeti elegiaci latini, Ovidio per primo, ma anche Catullo e Properzio, e sul tirocinio esegetico e imitativo delle Elegie di Ovidio. Come ricordava infatti il Rota nella Canzone composta per le nozze del Savioli, «Grato era il vegliar teco / sul chiaro esul di Ponto / vestendo a nuovo i prischi Amori e l’Arte».
Un successo, quello degli Amori, da ascriversi in massima parte alla perfetta aderenza delle elegie del Savioli a un orizzonte di attesa del tutto prevedibile ma nondimeno non facile da accendere. Qui l’autore, con atto genialmente intuitivo e con passaggio sottile, trascriveva in cifra poetica tendenze di gusto e attese emotive alle quali un pubblico femminile aristocratico era stato educato dalla commedia e dal romanzo psicologico francese non meno che dal genere pittorico delle fêtes galantes di Antoine Watteau e di François Boucher e delle fantasie galanti e mitologiche dei veneziani. Il Savioli rendeva nel contempo definitivi, in una veste più classica e insieme più attuale rispetto a quella dei drammi metastasiani e con una sigla inconfondibile e personalissima i modi della stilizzazione galante.
Negli Amori non ci sono solo le suggestioni delle fantasie mitologiche ed erotiche di Watteau e di Boucher. Anche da noi, da Giambattista Tiepolo in avanti, le raffigurazioni pittoriche suggerivano una concezione ideologica volta al privato e più socievole di quella tardo-barocca. La tendenza della nobiltà ad auto-rappresentarsi si vestiva delle forme aggraziate e leggere del barocchetto e i semidei moderni in un rapporto di prossimità/similarità venivano ammessi, quasi consanguinei, alla frequentazione, ai rituali, alle apoteosi di divinità minori, quali Ercole e Psiche. La ritualità mondana, nei suoi risvolti di dissolutezza, veniva assimilata ai riti di Venere e del suo corteggio di ninfe e naiadi, e amori, e Grazie, e geni del gioco e del riso, divinità di un Olimpo edonistico minore. Sotto il segno di Venere si colloca infatti, fin dall’ invocazione iniziale, tutto il ciclo poetico degli Amori.
O figlia alma d’Egioco,
leggiadro onor dell’acque,
per cui le Grazie apparvero
e ‘l riso al mondo nacque. […]
Accese a te le tenere
fanciulle alzan la mano:
sole ritrosa invocano
le antiche madri invano.
Te sulle corde Eolie
Saffo invitar solea,
quando a quiete i languidi
begli occhi Amor togliea.
E tu richiesta, o Venere,
sovente a lei scendesti,
posta in oblio l’ambrosia,
e i tetti aurei celesti.
Il gentil carro Idalio,
ch’ or le colombe addoppia,
lieve traea di passeri
nera amorosa coppia.
E mentre udir propizia
solevi il flebil canto,
tergean le dita rosee
della fanciulla il pianto.
E a noi pur anco insolito
ricerca il petto ardore,
e a noi l’esperta cetera
dolce risuona amore. […]
Meco i mortali innalzino
solo al tuo nome altari;
Citera tua divengano
il ciel, la terra, i mari.
Le suggestioni figurative presenti alla ideazione degli Amori vengono confermate da un altro componimento del Savioli, l’ode Amore e Psiche, pubblicata nel 1759. Il tema, disceso dall’archetipo alessandrino e divenuto esemplare nel rocaille, era già familiare all’immaginario pittorico del Savioli fino dai suoi primi anni di vita, poiché illustrato nel suo palazzo in un fregio cinquecentesco, oggi scomparso. Innegabili le suggestioni dalla pittura alla poesia e dalla poesia alla pittura. Tanto che, quando poi nel 1772 Francesco Dalla Casa affrescò sulla volta della camera della Udienza l’Apoteosi di Ercole, fu certo per precisa indicazione del conte Savioli che egli aggiunse, nel cielo dell’Olimpo, ai piedi di Giove, accanto a un Mercurio e a un amorino in festa, una tenera e trionfante figura di Psiche.
La presenza di Psiche, ormai accolta tra i Celesti, poteva suggerire allo spettatore 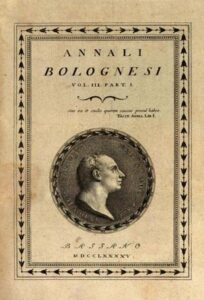 avvertito il trascorso temporale, le lunghe peripezie che l’eroina aveva dovuto sostenere prima dell’esito fortunato e dell’apoteosi finale. Si può qui riconoscere, nell’allusività del procedimento inventivo, quel pregio di saper suggerire più che descrivere che il famoso antiquario, il conte di Caylus, osservava nella Venere Anadiomene di Apelle, peraltro immaginata attraverso la descrizione di Plinio e le evocazioni dei poeti greci:
avvertito il trascorso temporale, le lunghe peripezie che l’eroina aveva dovuto sostenere prima dell’esito fortunato e dell’apoteosi finale. Si può qui riconoscere, nell’allusività del procedimento inventivo, quel pregio di saper suggerire più che descrivere che il famoso antiquario, il conte di Caylus, osservava nella Venere Anadiomene di Apelle, peraltro immaginata attraverso la descrizione di Plinio e le evocazioni dei poeti greci:
«La Venus d’Apelles est représentée dans le moment qu’elle paroit au jour […]. Deslors elle est occupée de sa parure naturelle, elle arrange et dispose ses cheveux; le soin qu’elle apporte pour les essuyer prouve qu’elle vient de sortir de l’eau, et tout ce qui rappelle une action précédente est une preuve aussi rare que costante du genie des artistes».
Ma per tornare agli Amori, diamo un’occhiata alla veste iconografica delle diverse edizioni, con tutta probabilità progettata e suggerita dallo stesso autore, pittore più che dilettante, aggregato fin da giovanissimo (1752) agli accademici d’onore della Clementina Accademia del disegno, fine conoscitore e noto collezionista di arti figurative. Era una pratica abbastanza frequente nel secolo XVIII: sappiamo che William Collins ideò medaglioni con eleganti teste all’antica per l’edizione delle sue Odi e che Rousseau indicò nei particolari i soggetti per le illustrazioni de La nouvelle Eloise, riferendovisi per le descrizioni. Un ruolo non secondario ricopriva infatti nell’uso dei connaisseurs settecenteschi, ai fini della coerenza estetica di un’opera, la veste grafica e iconografica che aveva la funzione di iscrivere l’opera in un preciso ambito di gusto.
Negli Amori lo scarto fra l’edizione del 1758 e quella del 1765 è notevole. Nell’edizione del 1758, nella bella incisione del frontespizio, con il motto en exergue «Scribere iussit Amor» (Ovidio, Heroides, Ep. IV), il poeta è raffigurato in un buen retiro campestre, un libro e la cetra ai suoi piedi, assorto nel comporre versi. Venere e un amorino, che sembrano usciti da un dipinto o da un’incisione di Boucher o di Oudry, assistono e presiedono all’opera. L’asimmetria della scena, l’impianto obliquo, il fogliame mosso e vaporoso sulla destra e la città pittoresca e turrita in fondo sulla sinistra, la tenera malizia e procacità della figura di Venere rimandano inequivocabilmente al gusto rococò. Come le numerose incisioni che nel testo aprono e chiudono le singole canzonette: nella diversità dei soggetti pertinenti alla divagazione galante o fantastica (amorini, fêtes galantes campestri, figurine che, immerse in un’atmosfera bucolica, coltivano i loro sentimenti in un picco lo dialogo), sono accomunati dall’impianto asimmetrico e dal decoro rococò della cornice.
Nel 1765, con l’edizione Riccomini di Lucca che reca nel frontespizio il motto ovidiano «Me Venus artificem tenero praefecit Amori» e un elegante medaglione all’antica, con una figura femminile di grazia un poco severa e ieratica, la Suonatrice di cetra di Carlo Bianconi, gli Amori da dodici salgono a ventiquattro e trovano una veste iconografica ormai neoclassica. Nell’arco di pochi anni il gusto figurativo dettato da Parigi era cambiato. Le reazioni profilatesi diffusamente in Germania e in Inghilterra negli anni cinquanta contro l’eccesso di decorazione e contro il rococò, visto dapprima come tema polarizzante pro e contro la cultura francese, avevano trovato un’eco risolutiva in Francia.
L’aggiornamento e l’adeguamento del Savioli alla nuova moda figurativa fu immediato, segno di una percezione affinata delle novità, di un gusto più attuale rispetto alla cultura grafica bolognese. Basti dire che le incisioni della maggior parte delle edizioni di poesia date a stampa a Bologna dopo il 1765 sono di un rococò delicato e calmo o di un classicismo fuso con elementi rococò. Suggestioni da Ercolano e segni di Neoclassicismo si trovano soltanto nelle edizioni romane, spesso in coincidenza con temi storici o con riedizioni di testi storici classici, ma anche qui raramente allo stato puro.
Il pronto aggiornamento del Savioli chiama in causa gli stretti contatti e la diretta collaborazione con Carlo Bianconi, artista inserito nei circuiti di cultura e di gusto artistico internazionale anche grazie al fratello Giovanni Ludovico, scienziato, medico personale del vescovo elettore di Assia Darmstadt ad Augusta e fondatore a Lipsia del Journal des savans d’Italie (in casa Bianconi nel 1755, nella breve sosta a Bologna nel viaggio da Dresda a Roma, soggiornò Winckelmann).
Non dimentichiamo poi che Ludovico Savioli era un appassionato collezionista di quadri e di incisioni, e che la sua raccolta spiccava per originalità nel panorama bolognese. Attraverso gli acquisti effettuati in Germania dal figlio Aurelio, Intendente alla Musica e Intendente alla Collezione delle stampe alla corte di Mannheim, esperto di opera italiana e a sua volta «bibliofilo appassionato e collezionista attento ed esperto di stampe ed incisioni», Ludovico Savioli aveva arricchito, nel corso degli anni, la sua collezione di opere di artisti tedeschi e fiamminghi. Per ereditare poi, nel 1788, alla prematura scomparsa del figlio, una collezione di stampe di ben 5408 esemplari, raccolti appunto da Aurelio in Palatinato e Baviera.
L’associazione visiva del testo degli Amori alla veste neoclassica dell’edizione integrale del 1765 presso il grande pubblico come presso i conoscitori (l’edizione del 1758 non varcò i limiti di una ristretta cerchia) dovette in parte orientare e determinare l’opinione della critica successiva che essi andassero situati in un’area neoclassica. Solo la critica recente, adottando una prospettiva più ampia, estesa all’intero Settecento europeo, riconobbe nell’opera un gusto rococò. Con la gaia, spregiudicata spensieratezza degli Amori, opera giovanile e ultima fatica poetica del Savioli, si chiude praticamente la breve e fulgida stagione della poesia erotica bolognese.
Da questo momento in avanti gli interessi del Savioli saranno di carattere storico e politico: la stesura degli Annali bolognesi e la traduzione degli Annali di Tacito, dedicata a Napoleone e mai portata a termine. Il rinnovato culto della storia che si era diffuso soprattutto in Francia verso il 1760, la visione dell’antichità come virile fonte di nuove forme e di nuove società non rimasero estranei all’interesse del Savioli e degli uomini di cultura bolognesi. Anche se, coerentemente col principio generale per cui sembra che il ricorso ai modelli e agli esempi dell’antichità si identifichi, il più delle volte, in ogni società, con i fini del presente, il culto della storia assumeva per i bolognesi e, in particolare per il Savioli, l’apparenza e il significato di una duplicatio erudita che tendeva a una identificazione della oligarchia cittadina con la romana Res Publica.
A questo punto, la competenza del Savioli in campo figurativo e il suo comprovato interesse per i temi storici spiegano il suo diretto e preciso intervento nel progetto decorativo del palazzo, sia per la scelta dei temi letterari e classici, sia per i temi storici. Era una prassi consolidata in una convenzione classicistica mai intermessa dal Rinascimento in avanti quella di privilegiare la inventio nell’elaborato d’arte, che prevedeva le istruzioni di un letterato al pittore nella scelta dei soggetti operata nell’immenso lessico di immagini della cultura classica. Negli stessi anni, dopo il 1773, a Milano il Parini dettava i Soggetti e appunti per pitture decorative per la decorazione di palazzo di Corte, palazzo Greppi e palazzo Belgioioso, nonché per i teloni del Teatro alla Scala.
Più che naturale che fosse il conte Savioli a dettare i soggetti realizzati e tradotti poi negli affreschi, nei dipinti e nei bassorilievi in stucco del palazzo di famiglia. E si può ipotizzare che il suo intervento si allargasse all’atteggiarsi fisico e psicologico delle figure e alla loro disposizione, data la sua familiarità con le figure classiche della storia e del mito e la sua conoscenza della sintassi del figurativo. Erano gli anni in cui Diderot, critico d’arte ai Salons, rivendicava come facoltà propria e quasi esclusiva del letterato quella di dare al pittore soggetti che potessero essere trasferiti tali e quali sulla tela, motivandola con una familiarità attenta e di lunga data con la pittura: «Cela vient apparemment de ce que mon imagination s’est assujettie de long main aux véritables règles de l’art, à force d’en regarder les productions».
La duplice competenza in campo letterario e figurativo non mancava certo al Savioli. Così le sue indicazioni per i paesaggi e per le figure femminili allegoriche à l’ancienne delle sovrapporte e al pittore Francesco Dalla Casa per le storie di Ercole nei pennacchi della sala dell’Udienza furono certo precise. Ancora più dirette, se possibile, devono essere state le sue indicazioni al pittore per le raffigurazioni di argomento storico, che celebravano le glorie della famiglia.
 I Fasti della famiglia Savioli sulle pareti del Salone, di mano di Pietro Fabbri, illustrano, nei medaglioni e nei grandi tableaux, i personaggi e i momenti salienti dell’ascesa sociale della casata, i cui particolari vengono precisati nei cartigli. Dagli antenati bolognesi Orsi e Caccianemici (da cui il Savioli pretendeva la famiglia discendesse) ai Savioli che, nel corso di tre secoli a Padova e a Verona avevano servito nelle armi, nelle leggi, negli ordini religiosi i Della Scala e la Repubblica Veneta, fino al ritratto di Alessandro Savioli senior, avo di Ludovico Vittorio, che aveva dato nuovo impulso e accelerato l’ascesa sociale della famiglia.
I Fasti della famiglia Savioli sulle pareti del Salone, di mano di Pietro Fabbri, illustrano, nei medaglioni e nei grandi tableaux, i personaggi e i momenti salienti dell’ascesa sociale della casata, i cui particolari vengono precisati nei cartigli. Dagli antenati bolognesi Orsi e Caccianemici (da cui il Savioli pretendeva la famiglia discendesse) ai Savioli che, nel corso di tre secoli a Padova e a Verona avevano servito nelle armi, nelle leggi, negli ordini religiosi i Della Scala e la Repubblica Veneta, fino al ritratto di Alessandro Savioli senior, avo di Ludovico Vittorio, che aveva dato nuovo impulso e accelerato l’ascesa sociale della famiglia.
Di Alessandro senior, erede per parte dei conti Corbelli oltre che del nome di un congruo patrimonio e della posizione nell’amministrazione imperiale, si sottolineava, nel cartiglio, il titolo comitale di nomina imperiale («Aulae Cesareae Comes Austriacae Dictionis»), il ruolo svolto come grand commis e amministratore delle Poste del governo austriaco a Venezia («Veredariis Summus Venetus Praefectus»), infine la concessione della cittadinanza bolognese da parte del Senato nel 1712.
In definitiva nei Fasti due erano le cose importanti che si voleva sottolineare. La prima era che per un Savioli la cittadinanza e l’accesso al Senato bolognese e alla massima carica cittadina era per così dire una sorta di ritorno a casa, alla dimora degli antenati. L’altra, non meno importante, era che il cursus honorum qui rappresentato si identificava con una funzione, con un pubblico servizio, onore e onere di una nobiltà che in passato aveva servito anche l’Impero. Come ultimo ma non minore merito della casata, illustrato nella scena degli antenati Orsi Caccianemici, veniva esibito quello di aver favorito la pace cittadina, con una saggia opera di conciliazione delle fazioni e un patto di concordia con gli Andalò, sotto l’egida delle istituzioni comunali che si ispiravano alla romana Res Publica.
Questa celebrazione della casata, assumeva dunque, per il conte Savioli, di là dagli aspetti contingenti, anche un significato più ampio. C’è un illustre precedente. A Bologna, in campo letterario, sulla fine degli anni sessanta, il culto della storia si manifestava al meglio nelle Memorie d’alcuni uomini illustri della famiglia Malvezzi. Qui fin dall’exordium («Chiunque vorrà agli antichi costumi della Romana Repubblica non che alle usanze nostre riguardare») veniva dichiarata da Filippo Maria Toselli, estensore del proemio, l’identificazione di sé e della oligarchia senatoria cittadina con la Res Publica romana, nel culto della memoria degli antenati, incentivo e ragion d’essere della virtù civile, dell’amor di patria, della fede serbata. Con esemplare rispondenza iconica a tale dichiarazione programmatica, le memorie dei Malvezzi, celebrate da un susseguirsi di prose ed elegie latine e di capitoli in rima di vari autori, sono precedute da tredici medaglie col ritratto del celebrando.
La visione storiografica e politica espressa nelle Memorie da un milieu gravitante intorno al Malvezzi, che comportava, con l’eloquente riferimento a Polibio, esplicitamente menzionato, e con l’apologetica dei Romani una interpretazione neoumanistica della storia e un vivo senso di continuità con un passato nobilitante, era presumibilmente la stessa che alimentava la passione intellettuale del Savioli e ne orientava la ricerca e gli studi. I Fasti della casata Savioli intendevano mostrare ai bolognesi che una antica nobiltà, già al servizio della Repubblica veneta e dell’Impero, si era ormai radicata, in un cammino di ritorno alle origini, nella oligarchia politica e culturale cittadina di Bologna, con il medesimo spirito illuministico di dedizione al pubblico bene.
In effetti sia la galleria di ritratti degli antenati e degli episodi agiografici come exempla dell’umanità raffigurati nei Fasti, sia la ripetizione in chiave attuale dei testi poetici degli elegiaci latini o la ripresa di un mito archetipico alessandrino come quello di Psiche partecipavano, nella visione del Savioli, della stessa concezione per cui il presente si saldava al passato meno recente, cercandovi esperienze di cultura e di vita da rinnovare e da portare a moderna perfezione nel segno della continuità.
Senonché, anche per un membro dell’aristocrazia guelfa bolognese come il Savioli, il culto della storia non poteva non caricarsi di altri significati più legati all’attualità. Lo induceva certo a interrogarsi sul presente, proprio negli anni in cui a Modena, a Milano, a Venezia si concepivano e si attuavano le riforme anticuriali. L’evoluzione successiva delle sue convinzioni personali lo porterà infatti molto vicino alle idee illuministiche, sia pure contenute da un cauto conservatorismo. Ludovico Vittorio era certo in una posizione molto più prudente di quella professata dal fratello cadetto Alessandro che, ben inserito con vari incarichi alla corte dell’Elettore di Baviera, nel 1786 verrà sospeso da ogni carica e fatto arrestare e processare da Carlo Teodoro come uno dei dirigenti della setta bavarese degli Illuminatenorden, che si ispirava al materialismo e all’ateismo di Helvétius e di d’Holbach.
Ma se percorsi e situazioni diverse avevano portato Ludovico Vittorio e Alessandro su posizioni molto distanti, di un prudente conservatorismo riformista l’uno, di progettazione di riforme tecnocratiche nel Principato l’altro (fino ad una deriva più radicale di ribaltamento del potere trono/altare), essi sembrano concordare in un concetto illuministico di base. Anche per Alessandro come per Ludovico Vittorio, l’esistenza della nobiltà si giustificava nell’utilità di un pubblico servizio al principe se, da vice-presidente della Accademia delle Scienze di Monaco, nel 1775 egli intitolava il suo primo discorso accademico Dell’influsso della virtù sul bene dello Stato e della necessità di ricompensarla.
Qui la virtus di ascendenza machiavelliana, valore radicato nella più antica tradizione europea, si saldava alla dignitas e all’honor dei nobili per servire lo Stato. A distanza di vent’anni Ludovico Vittorio che, conservatore realistico ancor più che illuminato, si era adeguato agli eventi e nel 1794 era forse stato uno degli ispiratori del tentativo di De Rolandis e Zamboni finalizzato a prendere il potere del Senato prima che arrivassero i Francesi, scriveva al cugino Gregorio Casali nel giugno 1797 da Parigi, un teatro dove la storia si era poco prima manifestata con evidenza inusitata e terribile.
Il Savioli affidava allo scritto una valutazione del ruolo della oligarchia nobiliare che era anche un personale bilancio di vita: «Ma tornando un momento ancora sulle idee che m’affliggono, quando sarà mai che coloro i quali costituiti in addietro dalla loro nascita, dalle loro ricchezze, dalla loro educazione e infine da un pregiudizio tanto più scusabile quanto più antico in istato di regger gli altri e predominarli si prestino una volta alle circostanze d’un’infallibile necessità? Quando cesseranno da maneggi oscuri coi quali non si comprano che la malevolenza e la diffidenza e quando impareranno a guardarsi dalle reti insidiose di coloro che sotto il velo della Teocrazia ricoprono viste ambiziose e interessate? Dio tolga che col mio dire io m’intenda di disprezzare ed invitarli a negligere la religione de’ nostri padri, la religione che mi è cara, nella quale trovano speranza i buoni, tema i cattivi. Che di più sacro agli uomini s’ella s’astragga dalla superstizione, dal bigottismo intollerante e dal fanatismo crudele?».
Questo suo prendere le distanze da chi faceva della religione un instrumentum regni, la sostanziale onestà di giudizio, un prudente atteggiamento di conciliazione in ogni situazione riconducono all’alveo di quella cultura bolognese aperta ad accogliere il nuovo ma che si era posta fin dall’inizio del secolo sotto il segno della moderazione. Era aspirazione di questi intellettuali conciliare ragione e rivelazione, legge di natura e legge divina, saggezza antica e tradizione cristiana, illuminismo e cattolicesimo senza che i rischi e le contraddizioni insiti in questo sincretismo venissero avvertiti. Basti pensare alla disposizione di Francesco Maria Zanotti nei confronti dello Stoicismo, «una scuola del mondo antico che poteva e doveva essere riportata nell’àmbito della tradizione cristiana».
Questo atteggiamento, per la generazione successiva, è esemplarmente testimoniato in un’antologia manoscritta di pensieri e di riflessioni in francese di celebri autori, collazionati dal conte Alfonso Malvezzi Bonfioli, recante sul frontespizio la dicitura Sans titre, 1783, dove massime e pensieri di Confucio, di La Bruyère, di Plinio e dal Vangelo, di Collins, di Pascal e di Pope, di Socrate e di Rousseau si succedono e si compenetrano in un panorama di saggezza senza tempo.
Al confronto, dobbiamo riconoscere al Savioli un’intelligenza europea, dovuta anche a relazioni e amicizie internazionali di più largo respiro, e una preveggenza politica perlomeno insolita nella oligarchia politica e culturale della sua città. E tuttavia rimanendo ben ancorato, come storico, al fondo classicistico che sostiene e nutre tutta la sua esperienza. Tant’è vero che mentre nella vicina Parma il Condillac, nel solco tracciato da Saint-Évremond, da Bayle, da Mandeville e attingendo alle Considerations di Montesquieu, elaborava nel suo Cours d’Etudes una visione storicistica che prescindeva dalla apologetica dei Romani, il Savioli si preparava alla stesura degli Annali bolognesi meditando sulle opere di Tacito.
Ilaria Campanacci Magnani

